Il Game Design della Metal Gear Saga: spazio, regia e libertà
Il game design è cambiato
All’epoca in cui cominciai a fare giochi, la tecnologia era molto limitata, perciò non potevo far vedere ai giocatori esattamente quello che avevo in testa. C’erano regole specifiche da seguire: quelle regole costituivano il game design. Era come giocare a scacchi: ogni cavallo, ad esempio, aveva il suo set predefinito di mosse. Oggi, possiamo rappresentare un cavallo che abbia tutta la libertà di movimento di un vero esemplare. Il game design è cambiato moltissimo.
Hideo Kojima, creatore della Metal Gear Saga, 2016, [ fonte ]
Tra il 1998 ed il 2015, la saga di Metal Gear Solid ha lasciato un’eredità importante nel mondo dei videogiochi, proponendo un concetto di gioco assimilabile ad un trìpode: una struttura che poggia in maniera equilibrata su storia, arte e gameplay. Quest’ultimo, evolutosi di pari passo con la tecnologia hardware a disposizione, si fonda sullo stealth ed annovera meccaniche che coinvolgono diversi elementi di gioco: l’ambiente, l’equipaggiamento, i movimenti, i nemici e l’azione. In questo primo speciale della rubrica sul game design interamente dedicato alla Metal Gear Saga analizzeremo la prima voce dell’elenco: l’ambiente.
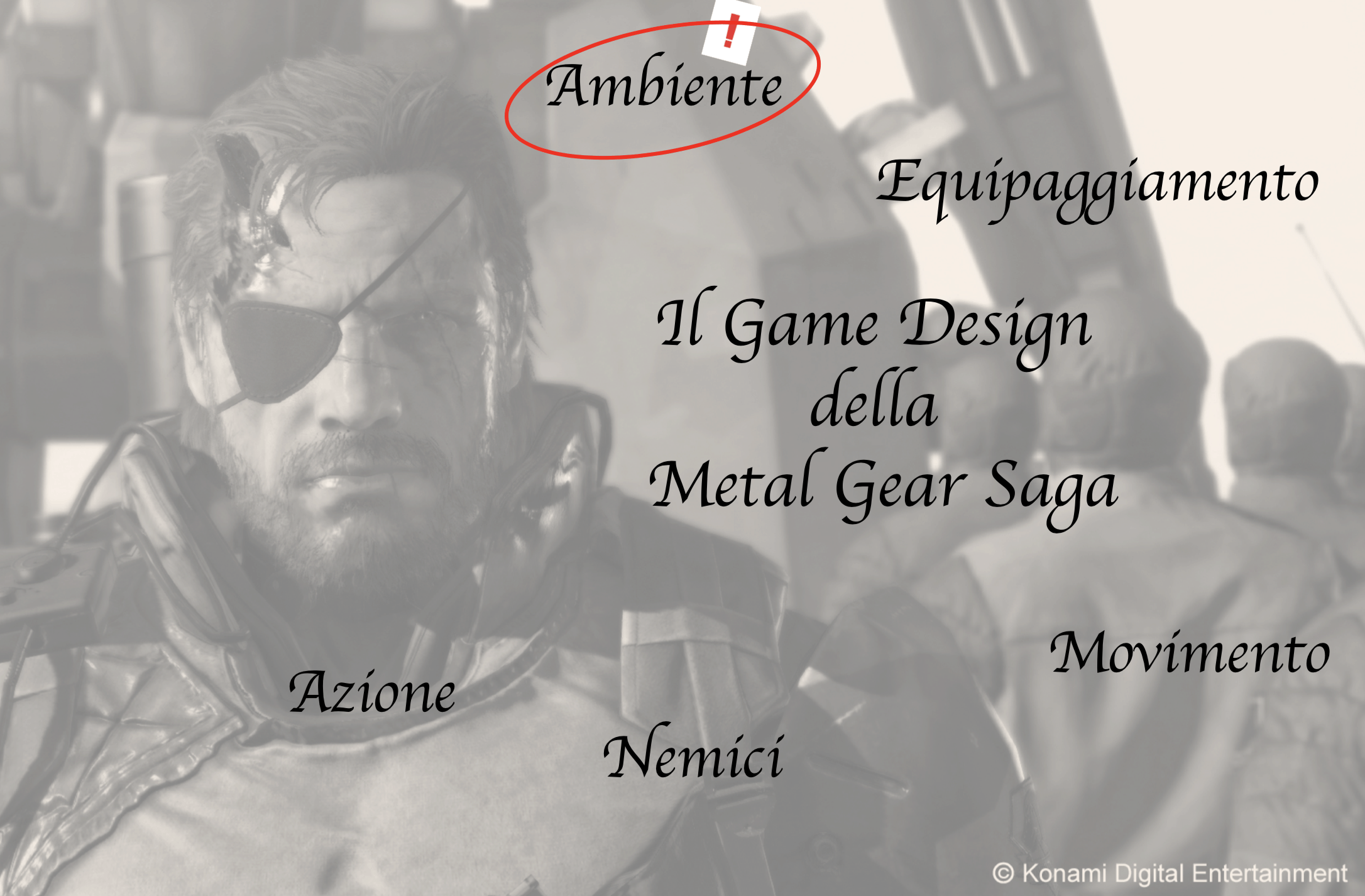
Ambiente
L’avventura di Solid Snake nel primo Metal Gear Solid (MGS1) si svolge nella stazione di Shadow Moses in Alaska, principalmente in ambienti chiusi dalle geometrie lineari: una serie di mini mappe separate da schermate di caricamento.

Snake può correre, accucciarsi, strisciare ed appiattirsi contro una superficie. Quest’ultima azione rappresenta la tecnica basilare dello stealth: dietro una copertura è possibile restare fuori dallo sguardo delle guardie e, al contempo, godere di una buona prospettiva per osservare l’area circostante.

Infatti, la telecamera di gioco è generalmente posizionata sopra il protagonista (non precisamente sulla verticale, bensì leggermente indietro) e non consente una visuale ampia dell’ambiente circostante. Per ovviare a questa limitazione, ci vengono dati degli strumenti: in primo luogo, la possibilità di passare alla prima persona in qualunque momento, seppur da fermi; in secondo luogo, il radar ed infine, come si diceva poc’anzi, i punti di osservazioni dalle coperture. Avvicinando Snake ad una superficie, la telecamera si abbassa e, cambiando di inclinazione, ci permette di osservare l’area di interesse.

A vederlo oggi MGS1 presenta un approccio schematico ed altamente geometrico alla tridimensionalità: non stupisce sapere che il level design sia stato in parte sviluppato ricostruendo le mappe con i mattoncini Lego e testando su di essi le possibili inquadrature da concedere alla telecamera di gioco. MGS1, infatti, uscì nel 1998, all’epoca delle prime avventure poligonali rese possibili dalla tecnologia di PlayStation: proprio la sua tridimensionalità gli fece guadagnare l’aggettivo “solid” che lo distingueva dai due precedenti capitoli bidimensionali per MSX2 (Metal Gear, 1987, e Metal Gear 2: Solid Snake, 1990).
Grazie dunque ad un meticoloso studio degli spazi, Kojima è in grado di raggiungere subito un traguardo essenziale, ossia quello di mostrarci ad ogni singola inquadratura sempre e solo ciò che vuole portare alla nostra attenzione. È solamente a partire da Metal Gear Solid 3: Subsistence (riedizione di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, MGS3) e, soprattutto, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (MGS4), che la telecamera subisce un’opera di ammodernamento che la ancora saldamente alle spalle del protagonista, come in una qualunque avventura in terza persona contemporanea.

Alle volte, varcando le soglie di una determinata area, le inquadrature canoniche vengono sostituite da inquadrature fisse: altamente cinematografiche, coreografiche e suggestive, quest’ultime sono incaricate di veicolare la gravitas di una particolare situazione. Kojima, in altre parole, è un regista onnipresente nel gioco: la sua direzione non è mai limitata ai filmati, bensì invade anche i momenti di esplorazione ed azione. Un ulteriore tocco di classe è dato dall’interattività concessa durante i filmati di intermezzo: premendo il bottone indicato, si possono visualizzare immagini alternative al video. Solitamente dei flashback o dei ricordi, visualizzati a schermo direttamente dai pensieri del protagonista.
MGS1 e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (MGS2) offrono mondi di gioco composti da piccole mappe concatenate a caricamento individuale. Questo schema viene rotto in MGS3, in cui l’azione si svolge in gran parte all’aperto, nella foresta e nel deserto russi.

L’apertura delle aree di gioco coincide con l’aumento delle capacità del nostro personaggio: Big Boss può arrampicarsi sugli alberi, interagire con la flora e fauna locali procacciandosi del cibo oppure facendone un’arma contro i nemici: avete mai provato a colpire un nido di vespe in prossimità di un avversario? Gli obiettivi da infiltrare sono dotati di accessi multipli, alcuni più sguarniti di altri. Esistono oggetti o addirittura piccoli edifici interamente distruttibili: è possibile far esplodere i depositi delle razioni, affamando così i soldati che, come dicono nella pubblicità, non ci “vedranno più dalla fame”. Letteralmente. I soldati sono dotati di stamina, proprio come Big Boss, perciò la fame induce una riduzione del loro cono visivo ed infiltrarsi diviene più facile. Se poi si è capaci di giocare ai livelli di un Sabaku (le cui “run veterane” sono state utilissime per la stesura del presente articolo), è possibile lasciare del cibo marcio in giro per il campo di battaglia ed aspettare che le affamatissime guardie lo mangino e, di conseguenza, si sentano male lasciando campo libero.

MGS4 ha il grande merito di proseguire l’opera di costruzione di mappe aperte iniziata da Snake Eater: per quanto sia oggettivo che il quarto capitolo possa essere completato in tempi di gioco effettivo estremamente ridotti, il gameplay offerto risulta estremamente vario e denso di possibilità ed alternative. Le aree, sempre separate da caricamenti, sono mappe molto grandi in cui il concetto di scorciatoia, timidamente presente fino ad ora nella saga, viene potenziato notevolmente: il numero di percorsi possibili per arrivare da un punto A ad un punto B si moltiplica esponenzialmente. Laddove Shadow Moses e Big Shell facevano grande uso della modularità geometrica, della linearità e, in alcuni casi, persino del backtracking (l’attivazione della scheda termo-sensibile del Metal Gear Rex, il girovagare continuo tra le varie strutture della piattaforma di MGS2), le zone di guerra di Guns of the Patriots offrono una visione del level design diametralmente opposta.
L’evoluzione del concetto di libertà di azione contribuisce enormemente alle “tactical espionage missions” di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (MGS5): questo quinto ed ultimo capitolo, sviluppato appena prima della poco amichevole uscita di Kojima da Konami, porta la serie in un ambiente sandbox. Il risultato è sorprendente: le meccaniche stealth, fino ad ora espresse principalmente in giochi dall’avanzamento lineare, si adattano meravigliosamente a questa nuova struttura. Il mondo di gioco diviene “granulare”: ampi spazi, virtualmente vuoti, separano gli avamposti nemici da infiltrare durante le missioni.

Per la prima volta fa capolino il ciclo notte giorno: l’oscurità è generalmente amica di Venom Snake. Il ritmo della storia, fino ad ora sempre incalzante, viene spezzettato e diluito in una serie di obiettivi che, dal punto di vista del gameplay, sono essenzialmente indipendenti fra loro. Tuttavia, forte delle consuete genialate narrative e di una fluidità di gioco ignota alla serie, l’esperienza risulta inconfondibilmente degna di un Metal Gear Solid.
La sovrapposizione di storia e gameplay è uno degli aspetti più caratteristici della saga e si manifesta nelle maniere più disparate. Si pensi alla celeberrima lotta con Psycho Mantis, in cui per superare i suoi poteri psichici bisogna inserire il controller nella seconda porta della consolle. Oppure si pensi alla fase di esplorazione di Arsenal Gear in MGS2: Raiden, fino a quel punto un soldato in missione, scopre di essere un burattino imprigionato in una sofisticata simulazione architettata da un’intelligenza artificiale occulta che lo ha manovrato facendo le veci del colonnello Campbell. L’intelligenza artificiale viene attaccata da un virus e l’inganno viene svelato: improvvisamente siamo tartassati di chiamate via codec che ci mostrano un Campbell delirante. Appare addirittura la schermata del game over, ma non si tratta di “missione fallita” bensì di “fission mailed”: la quarta parete è frantumata.

L’ambiente, poi, ha spesso un effetto sul protagonista, per esempio il freddo procura starnuti che possono essere uditi dalle guardie; vicendevolmente, il protagonista ha un effetto sull’ambiente: si lasciano tracce sulla neve in MGS1, si piega l’erba su cui si è camminato in MGS3.
Verso il futuro
Dal poco che si è visto di Death Stranding, si può speculare che siano molti gli elementi in comune con The Phantom Pain: ambienti aperti e grandi mappe. Non è impensabile che alcune delle idee alla base di MGS5 fossero state immaginate per un altro gioco. Tuttavia, dietrologie e speculazioni non valgono una certezza: negli ultimi trent’anni Hideo Kojima non ha mai prodotto un gioco non divertente. Possiamo stare tranquilli.
